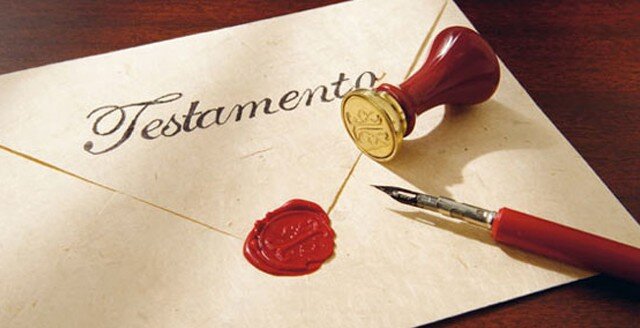Vogliamo affrontare in questo breve articolo teorico-pratico un caso non così infrequente nella prassi: ossia l’eventualità in cui, dopo la presentazione di una dichiarazione di successione, venga scoperto un testamento idoneo a modificare la precedente devoluzione ereditaria.
A prescindere dal fatto che la prima dichiarazione di successione sia stata compilata considerando i presupposti giuridici di una devoluzione per legge o quelli di un testamento (anteriore), in presenza di una nuova volontà testamentaria, anche solo parzialmente incompatibile con la prima devoluzione, sarà necessario andare a modificare, integrare o sostituire, quanto già dichiarato ai fini fiscali.
La fattispecie in esame va infatti ricondotta all’ipotesi di cui all’art. 28 comma 6 del Testo Unico Successioni (Dlgs 346/1990), norma che disciplina l’onere di procedere a una modificazione/sostituzione della dichiarazione di successione già presentata nel caso in cui si sia registrato il sopraggiungere di un evento idoneo a dar luogo ad un mutamento della devoluzione ereditaria precedentemente rappresentata al Fisco.
Una volta effettuato il necessario adempimento della pubblicazione del testamento presso un Notaio (“verbale di pubblicazione” in caso di testamento olografo o “verbale di passaggio dal repertorio degli atti di ultima volontà al repertorio degli atti tra vivi” o “verbale di registrazione” in caso di testamento pubblico), sarà necessario quindi valutare il da farsi alla luce delle disposizioni testamentarie sopraggiunte: a seconda del contenuto del testamento successivo e della eventuale compatibilità/incompatibilità rispetto al primo testamento (o alla successione per legge), potrà rendersi necessaria la presentazione di una semplice dichiarazione di successione “sostitutiva” (idonea a integrare o modificare, anche solo parzialmente il primo documento registrato) oppure di una vera e propria “nuova prima dichiarazione” che va ad annullare la prima, sostituendola integralmente.
Una dichiarazione di successione meramente “sostitutiva” potrebbe reputarsi sufficiente, ad esempio, nel caso in cui non vi sia modifica dei soggetti indicati come eredi/legatari e possa ancora mantenersi la coincidenza del medesimo (originario) soggetto dichiarante. In questo caso, pertanto, il primo dichiarante chiederà la registrazione di una dichiarazione di successione sostitutiva rappresentando gli elementi di novità rispetto a quanto in precedenza rappresentato.
Una vera e propria “nuova prima dichiarazione” (che annulla in toto e sostituisce la precedente dichiarazione) si renderà invece sicuramente necessaria nel caso in cui il precedente soggetto che aveva firmato la prima dichiarazione non sia più tra i soggetti contemplati nel testamento sopravvenuto. In questo caso, l’originario dichiarante non rientrerà più tra i soggetti legittimati/obbligati alla presentazione della dichiarazione e sarà necessario che il nuovo documento venga firmato e registrato da uno dei “nuovi” eredi.
Vediamo alcuni esempi.
ESEMPIO 1. Una delle ipotesi più frequenti è quella che concerne la situazione in cui vi sia stata una dichiarazione di successione firmata e presentata da uno degli eredi designati per legge (es. da uno dei fratelli del defunto che non aveva né coniuge e né figli) che venga poi ribaltata dalla scoperta di un testamento in cui il De Cuius nominava quale erede universale un estraneo (o solo alcuni dei fratelli, ma comunque non contemplando il soggetto che aveva effettuato la prima dichiarazione).
ESEMPIO 2. Un altro classico caso è quello della dichiarazione di successione presentata sulla base di un testamento anteriore in cui il testatore aveva designato quale erede universale un parente collaterale o un estraneo, ma poi si rinviene un testamento (successivo al primo) in cui il testatore effettua un riconoscimento di figlio con contestuale nomina ad erede del medesimo.
In tali casi - è evidente - la “nuova prima dichiarazione di successione” non potrà essere più presentata dal medesimo soggetto che aveva richiesto l’originaria registrazione (e corrisposto le imposte dovute!) riscontrandosi un difetto di legittimazione che non gli consente di procedere con un nuovo adempimento.
Ed allora, come si procede?
Alla luce della prassi più volte confermata dall’Agenzia, il “nuovo” dichiarante (soggetto non firmatario della prima dichiarazione) dovrà presentare una nuova “prima” dichiarazione per il tramite dell'ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate (questo perché l’attuale sistema telematico di registrazione, fatta eccezione per il caso dei legati, non consente di trasmettere autonomamente - per lo stesso defunto - due separate dichiarazioni da parte di dichiaranti diversi) e corrispondere ex novo tutte le imposte a suo carico. La trasmissione telematica sarà in questo caso curata direttamente dai funzionari dell'Agenzia, a cui il nuovo dichiarante dovrà fornire i nuovi elementi da dichiarare (consegnando una bozza dichiarazione di successione in formato ".diz" e/o una bozza in formato cartaceo).
Dal canto suo, il precedente dichiarante – che aveva già corrisposto le imposte in occasione della precedente dichiarazione – potrà chiedere a rimborso quanto originariamente versato, premunendosi di rappresentare al fisco la specifica situazione e fornendo idonea documentazione a supporto della sua richiesta.
Quanto al termine di cui all’art. 31 comma 1, D.lgs. 346/1990 (in forza del quale la dichiarazione di successione deve essere presentata entro dodici mesi dalla data di apertura della successione), si ricorda che la decorrenza non ha però un termine iniziale sempre fisso.
Vi sono infatti dei casi particolari, come quello oggetto del presente articolo, che contempla appunto l’ipotesi di eventi verificatisi in un momento successivo alla data del decesso e che il legislatore ha deciso di tenere in considerazione per poi consentire una sorta di spostamento in avanti del termine ordinario (in questo altro articolo abbiamo invece parlato del caso della rinuncia all'eredità effettuata dopo la presentazione della dichiarazione di successione).
Entra quindi in gioco il disposto dell’art. 31 comma 2 lett. “e”, del Testo Unico Successioni (D.lgs. 346/1990) e il termine di dodici mesi per la presentazione della dichiarazione di successione decorrerà non più dalla data dell’apertura della successione, ma dalla data in cui i “nuovi” eredi/legatari avranno avuto notizia del contenuto del testamento prima a loro sconosciuto.
È infatti al verificarsi di tale “nuovo” evento che il soggetto adesso obbligato alla presentazione potrà dirsi concretamente in grado di poter rappresentare all’Agenzia delle Entrate l’esatto quadro di soggetti effettivamente interessati dalla devoluzione ereditaria.
Infine, quanto alle intestazioni catastali degli immobili eventualmente presenti nel patrimonio, nel caso di modifica soggettiva dei beneficiari (o delle quote devolute) conseguente alla "nuova" devoluzione testamentaria, sarà necessario effettuare le dovute correzioni mediante la presentazione di apposite istanze e richieste di volture catastali.
Avv. Giovanni Quaresima | Successioni.legal
Riproduzione riservata ©
Per maggiori informazioni contattaci